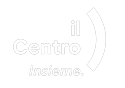La scuola dell’obbligo rappresenta uno degli spazi più decisivi nella formazione di ogni individuo. Non solo vi si trasmettono conoscenze, ma si apprendono anche regole, linguaggi, relazioni. I giovani imparano a decentrarsi, ad ascoltare l’altro, a costruire il proprio posto all’interno di un gruppo. Questa dinamica, intrinsecamente fragile, viene oggi messa alla prova da un oggetto piccolo, apparentemente neutro: lo smartphone.
Negli ultimi anni, l’impiego dello smartphone si è diffuso in modo rapido e pervasivo anche tra i giovani. In Svizzera, il 96% degli adolescenti tra i 12 e i 13 anni possiede un dispositivo personale (Külling-Knecht et al., 2024). Il tempo medio di utilizzo si attesta intorno alle 3 ore e 25 minuti in settimana e 4 ore e 25 minuti nel fine settimana (Külling-Knecht et al., 2024). Parallelamente, circa il 17 % dei giovani manifesta segnali compatibili con un uso problematico, con difficoltà di autoregolazione, sintomi di astinenza e utilizzo frequente anche nelle ore notturne (Haug et al., 2015). Oggigiorno, dunque, questi comportamenti non riguardano una minoranza marginale, ma una porzione significativa della popolazione scolastica.
A fronte di questa crescente esposizione digitale, la letteratura scientifica segnala con chiarezza una serie di rischi concreti e in progressiva espansione: disturbi del sonno, difficoltà dell’attenzione, isolamento sociale, maggiore vulnerabilità psicologica, alterazioni dello sviluppo fisico. Di fronte a tale scenario, non è più sufficiente confidare nella buona volontà dei singoli genitori – spesso a loro volta disorientati – o nelle scelte frammentarie e diversificate dei singoli istituti scolastici.
Intervenire oggi, con decisione e lungimiranza, significa garantire ai giovani uno sviluppo più sano e armonioso, evitando inoltre alla collettività di gestire costi sociali ed economici legati a disagi accumulati e difficilmente reversibili.
Il sonno è uno degli ambiti che maggiormente risente degli effetti dell’uso eccessivo dello smartphone. L’uso dei dispositivi nelle ore serali è sistematicamente associato a difficoltà nell’addormentamento, riduzione della durata del sonno e aumento della sonnolenza diurna. L’esposizione alla luce degli schermi compromette la produzione di melatonina e ritarda l’inizio della fase di riposo fisiologico. Diversi studi evidenziano come i giovani che utilizzano dispositivi digitali prima di dormire tendano a coricarsi più tardi, a dormire meno e a presentare maggiori segnali di affaticamento durante il giorno (Chu et al., 2025; de Sá et al., 2023).
Non concedere l’uso dello smartphone durante l’orario scolastico rappresenta una misura indiretta ma concreta per limitare l’esposizione complessiva e interrompere l’automatismo dell’accesso costante al dispositivo. Ridurre il tempo digitale nelle ore centrali della giornata contribuisce a ristabilire un confine più netto tra attività e riposo, favorendo un uso più regolato anche nel contesto domestico. In questo senso, la scuola può svolgere un ruolo educativo fondamentale nella costruzione di abitudini sane legate al sonno e alla gestione del tempo.
Oltre al sonno, anche la sfera cognitiva risente in modo marcato dell’iperstimolazione digitale. L’ambiente digitale, per sua natura, favorisce un’attenzione breve, frammentata, continuamente interrotta da notifiche, messaggi, suoni. Revisioni sistematiche della letteratura dimostrano che un uso intenso dello smartphone si associa a una riduzione delle capacità dell’attenzione, riduzione delle abilità linguistiche, maggior impulsività e difficoltà nella memoria (Massaroni et al., 2023; Wallace et al., 2023). Nei bambini e negli adolescenti, questo si traduce in difficoltà a seguire spiegazioni, portare a termine compiti, gestire l’attesa e la noia. Negli ultimi anni, si è inoltre osservato un incremento rilevante delle diagnosi di disturbi del neurosviluppo, in particolare dell’ADHD: una parte consistente della letteratura ipotizza che l’eccesso di stimolazione digitale — costante, veloce, gratificante — possa agire come fattore di vulnerabilità per soggetti predisposti, anticipando l’emergere di sintomi oppure aggravandoli (Thorell et al., 2022). Lasciare il telefono a casa è una condizione necessaria per ricostruire la continuità cognitiva richiesta dall’apprendimento scolastico andando a rimuovere un ostacolo ambientale reale al funzionamento della mente e, per molti studenti, rappresenta una forma concreta di prevenzione neuropsicologica.
A queste ricadute cognitive si affiancano conseguenze altrettanto rilevanti sul piano relazionale. La socializzazione scolastica è una componente centrale dello sviluppo nei giovani. Le relazioni tra pari favoriscono l’acquisizione di competenze fondamentali come l’autoregolazione emotiva, l’empatia, la cooperazione e la capacità di risoluzione dei conflitti (Hwang, 2025). Questi processi avvengono nel contatto diretto e richiedono tempo, attenzione e continuità. Diversi studi hanno evidenziato che l’uso intensivo dello smartphone riduce le occasioni di interazione reale e può ostacolare lo sviluppo socio-emotivo, soprattutto nei contesti informali come le pause scolastiche (Adeyemi, 2025; Twenge & Campbell, 2018). Limitare l’accesso al dispositivo durante l’orario scolastico significa preservare lo spazio relazionale e garantire le condizioni necessarie all’apprendimento sociale.
Alla dimensione cognitiva e relazionale si affianca un aspetto altrettanto rilevante: la salute mentale dei giovani. Un numero crescente di studi longitudinali e meta-analitici ha evidenziato una correlazione tra l’uso intensivo dello smartphone e un aumento di sintomi depressivi, ansia, instabilità emotiva e difficoltà di autoregolazione. Le piattaforme digitali, progettate per massimizzare l’interazione, espongono i giovani a una stimolazione continua, a confronti sociali ripetuti e a forme di pressione identitaria particolarmente invasive in età evolutiva (Sohn et al., 2019). Negli ultimi anni, inoltre, è stata osservata una crescente associazione tra l’uso dei social media e l’emergere di disturbi del comportamento alimentare (DCA), in particolare tra preadolescenti e adolescenti. L’esposizione costante a modelli estetici irrealistici, algoritmi che amplificano contenuti legati al controllo del corpo e pratiche di autovalutazione socialmente condizionata ha contribuito all’intensificarsi di fenomeni di dismorfia, restrizione alimentare e insoddisfazione corporea (Massaroni et al., 2023). In questo contesto, limitare l’uso dello smartphone durante l’orario scolastico rappresenta anche una forma di prevenzione delle malattie psichiche. La riduzione della pressione sociale digitale favorisce un ambiente più protetto, in cui il confronto si svolge in presenza e in modo mediato da relazioni educative, non algoritmiche.
Oltre agli aspetti cognitivi, relazionali e psicologici, va considerata anche la dimensione corporea dello sviluppo. L’uso prolungato dello smartphone in età evolutiva è stato associato a un aumento della sedentarietà e a una riduzione dell’attività fisica spontanea, questo comporta un rischio accresciuto di sovrappeso e obesità, un rallentamento nello sviluppo delle competenze motorie e un peggioramento dell’equilibrio posturale (Fang et al., 2019; Twenge & Campbell, 2018). In questo quadro la scuola dell’obbligo, come ambiente educativo integrale, ha anche la responsabilità di promuovere esperienze corporee attive e variate, non mediate da uno schermo. Limitare l’uso dello smartphone durante la giornata scolastica significa contrastare l’inattività prolungata e favorire il gioco libero, il movimento spontaneo, l’interazione fisica con l’ambiente. In assenza di dispositivi personali, i giovani tendono a utilizzare le pause in modo più attivo, con ricadute documentate sul benessere fisico, cognitivo e motivazionale (Pawlowski et al., 2021).
Bibliografia
Adeyemi, V. (2025). The Impact of Digital Technology on a Child’s Cognitive and Social Development: Implications for Education – Premier Science. https://premierscience.com/pjp-25-808/
Chu, Y., Oh, Y., Gwon, M., Hwang, S., Jeong, H., Kim, H.-W., Kim, K., & Kim, Y. H. (2025). Dose-response analysis of smartphone usage and self-reported sleep quality: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Journal of Clinical Sleep Medicine, 19(3), 621–630. https://doi.org/10.5664/jcsm.10392
de Sá, S., Baião, A., Marques, H., Marques, M. do C., Reis, M. J., Dias, S., & Catarino, M. (2023). The Influence of Smartphones on Adolescent Sleep: A Systematic Literature Review. Nursing Reports, 13(2), 612–621. https://doi.org/10.3390/nursrep13020054
Fang, K., Mu, M., Liu, K., & He, Y. (2019). Screen time and childhood overweight/obesity: A systematic review and meta-analysis. Child: Care, Health and Development, 45(5), 744–753. https://doi.org/10.1111/cch.12701
Haug, S., Castro, R. P., Kwon, M., Filler, A., Kowatsch, T., & Schaub, M. P. (2015). Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. Journal of Behavioral Addictions, 4(4), 299–307. https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.037
Hwang, J. young. (2025). The function of emotional intelligence in conflict resolution among adolescents. World Journal of Advanced Research and Reviews, 26(1), 3158–3169. https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.1.1429
Külling-Knecht, C., Waller, G., Willemse, I., Deda-Bröchin, S., Suter, L., Streule, P., Settegrana, N., Jochim, M., Bernath, J., & Süss, D. (2024). JAMES Study. ZHAW Applied Psychology. https://www.zhaw.ch/en/psychology/research/media-psychology/media-use/james
Massaroni, V., Delle Donne, V., Marra, C., Arcangeli, V., & Chieffo, D. P. R. (2023). The Relationship between Language and Technology: How Screen Time Affects Language Development in Early Life-A Systematic Review. Brain Sciences, 14(1), 27. https://doi.org/10.3390/brainsci14010027
Pawlowski, C. S., Nielsen, J. V., & Schmidt, T. (2021). A Ban on Smartphone Usage during Recess Increased Children’s Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1907. https://doi.org/10.3390/ijerph18041907
Sohn, S. Y., Rees, P., Wildridge, B., Kalk, N. J., & Carter, B. (2019). Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: A systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence. BMC Psychiatry, 19(1), 356. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2350-x
Thorell, L., Burén, J., Wiman, J., Sandberg, D., & Nutley, S. (2022). Longitudinal associations between digital media use and ADHD symptoms in children and adolescents: A systematic literature review. European Child & Adolescent Psychiatry, 33, 1–24. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02130-3
Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. Preventive Medicine Reports, 12, 271–283. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003
Wallace, J., Boers, E., Ouellet, J., Afzali, M. H., & Conrod, P. (2023). Screen time, impulsivity, neuropsychological functions and their relationship to growth in adolescent attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms. Scientific Reports, 13(1), 18108. https://doi.org/10.1038/s41598-023-44105-7